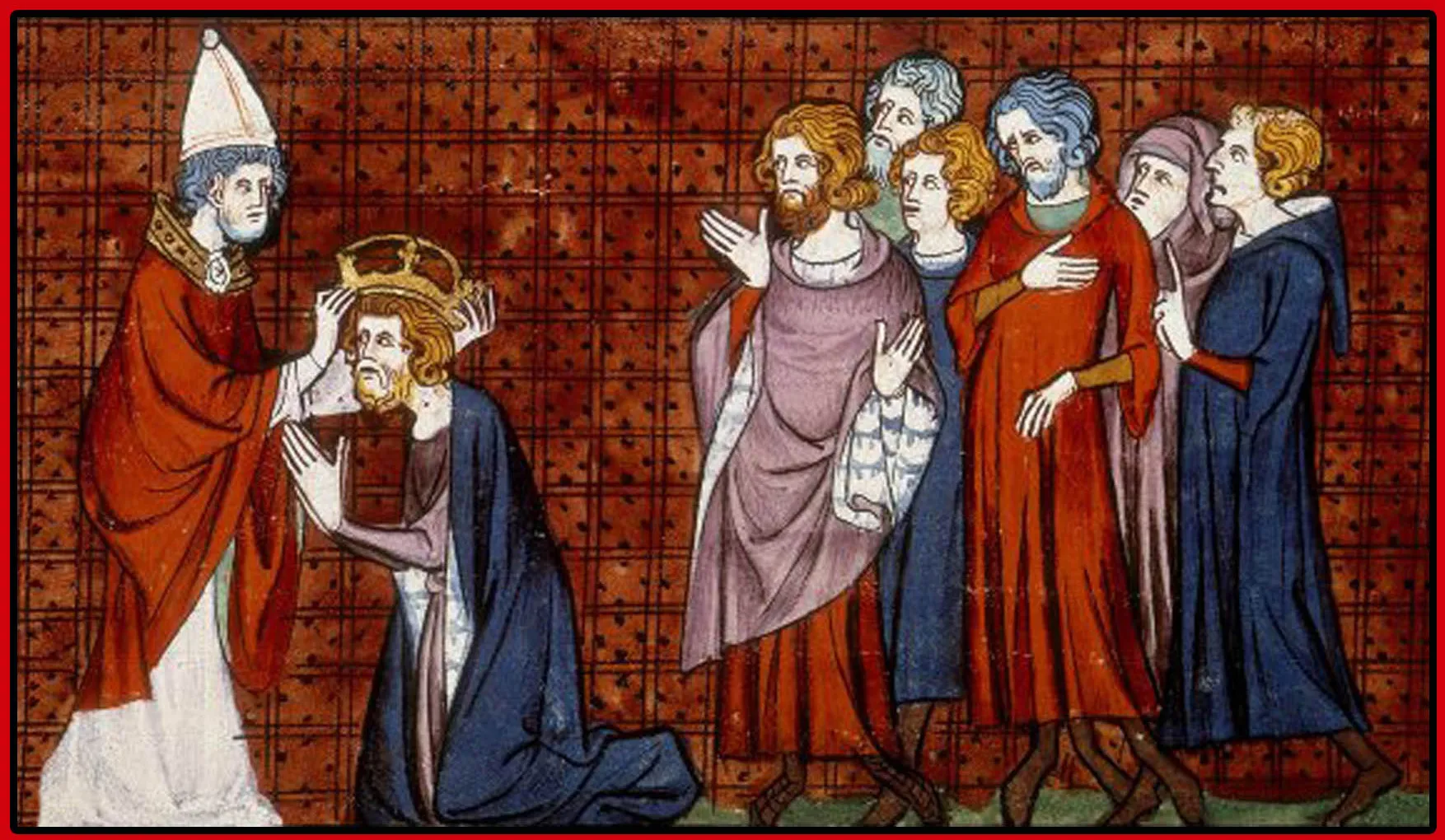La “caduta” di Satana, così come quella di Adamo ed Eva, può essere interpretata come un atto di ribellione metafisica, che nasce dall’illusione di essere “qualcosa” separato dalla totalità divina. Dio, nella concezione filosofico-teologica esposta, non è semplicemente una divinità personale o un’entità distinta, ma coincide con la realtà universale totale, indivisa e irrelata. Considerarsi “altro-da-Dio” equivale a frammentare l’indivisibile, a rompere l’unità con ciò che è reale e assoluto.
Il termine “diavolo” stesso deriva dal greco diabàllo, che significa “separare”. Il diavolo, pertanto, simboleggia il principio separatore che introduce la dualità, creando l’illusione di una frattura tra molteplici alterità nel reale. Questa separazione, però, è solo apparente: un velo, un’illusione, una mâyâ, come viene chiamata nella tradizione indù, che offusca la visione dell’unità fondamentale.
La manifestazione: Dio, il non-essere e le creature
Per manifestarsi, Dio pone simbolicamente un aspetto di sé nel non-essere, ossia nel punto più distante dalla pienezza dell’essere. Tale atto creativo genera un abisso tra Dio e questa manifestazione frammentaria, abisso che Egli colma attraverso ciò che noi chiamiamo “esseri” o “creature”. L’idea è che le creature rappresentino i ponti attraverso cui Dio stesso si riconduce all’unità, integrando il frammento nel tutto.
Meister Eckhart illustra poeticamente questo concetto con un’immagine simbolica: “La terra fugge il cielo; se fugge verso il basso, giunge al cielo dal basso […]. La terra non può fuggire tanto verso il basso, che il cielo non fluisca in essa ed imprima in essa la sua potenza e la renda feconda, le piaccia o no” (Sermoni tedeschi. Ave, gratia plèna). In altre parole, anche il punto più distante da Dio è intriso della sua presenza. Il cielo, inteso come simbolo dell’essere divino, non smette mai di permeare la terra, simbolo del non-essere o della separazione apparente. La fecondità che ne deriva è l’affermazione che nulla è realmente escluso dall’unità divina.

La non-separazione: Dio, le creature e l’uomo
Il pensiero di Eckhart si approfondisce ulteriormente nell’affermazione che non esiste separazione tra Dio e tutte le cose, perché Dio è più intimo a tutte le cose di quanto queste lo siano a sé stesse. Questa intimità radicale implica che la percezione della separazione tra Dio e il creato sia un’illusione, una proiezione della mente umana che non coglie la vera natura del reale.
Eckhart sottolinea che la stessa unità che lega Dio al creato dovrebbe caratterizzare il rapporto dell’uomo con tutte le cose. Perché ciò avvenga, l’uomo deve abbandonare ogni attaccamento a sé stesso, deve diventare niente in sé stesso, in uno stato di distacco assoluto. Questo stato di non-separazione non è un vuoto sterile, ma piuttosto una pienezza in cui l’uomo non solo si unisce al tutto, ma diventa tutte le cose. Eckhart spiega: “Non esiste separazione tra Dio e tutte le cose, perché Dio è in tutte le cose: è più intimo ad esse di quanto non lo siano a se stesse. Così, non esiste separazione tra Dio e tutte le cose. Nello stesso modo, non deve esistere separazione tra l’uomo e tutte le cose; ovvero, l’uomo deve essere niente in se stesso, assolutamente distaccato da se stesso: così non esiste separazione tra lui e tutte le cose, ed è tutte le cose. Infatti, nella misura in cui non sei niente in te stesso, nella stessa misura sei tutte le cose, e non esiste separazione tra te e le cose. Perciò, nella misura in cui non sei separato da tutte le cose, in questa misura sei Dio e tutte le cose, perché la divinità di Dio consiste nel fatto che non v’è separazione tra lui e le cose. Dunque, l’uomo, in cui non esiste separazione tra lui e le cose, coglie la divinità là dove Dio stesso la coglie” (Sermoni tedeschi. Ecce mitto angelum meum).
In altre parole, l’essere umano, abbandonando il proprio ego e la percezione illusoria di separazione, può cogliere la divinità nella stessa modalità con cui Dio stesso la coglie. Questo significa che l’uomo, in quanto parte integrante della totalità divina, non è un’entità distinta ma partecipa alla stessa essenza divina.
La caduta come opportunità di ritorno
Se la caduta di Satana, Adamo ed Eva rappresenta il culmine dell’illusione di separazione, essa può anche essere letta come un’opportunità per il ritorno all’unità. Nel simbolismo cristiano, la caduta non è mai definitiva, ma sempre accompagnata dalla possibilità di redenzione, di riconciliazione con il tutto. Questa visione è coerente con la prospettiva di Eckhart, che invita l’uomo a cogliere la divinità non come qualcosa di distante, ma come la realtà più immediata e intima.
La “caduta” è, dunque, un mito cosmico che descrive non solo l’illusione della separazione, ma anche il processo attraverso cui Dio stesso si manifesta e si riconduce all’unità. L’uomo, nella sua essenza più profonda, è chiamato a partecipare a questa dinamica, abbandonando ogni pretesa di individualità separata e riscoprendo la propria identità divina. Solo in questa consapevolezza si dissolve l’illusione del separatore, il diabàllo, e si realizza l’unità con tutte le cose.