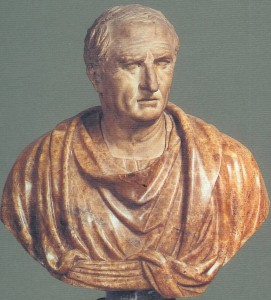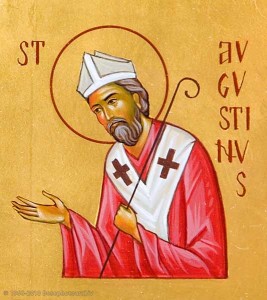Tratto dal mio “La Letteratura Italiana – Dalle origini al primo Novecento”, Eurilink University Press, 2022, pp. 42-43
“…Verso la metà dell’XI secolo, tuttavia, qualcosa cominciò a cambiare. Qualcuno decise di mettersi in concorrenza con la Chiesa. “Perché devono essere solo loro a insegnare, a scegliere le materie e i programmi? Perché la Bibbia deve essere l’unico manuale in uso di storia, geografia, letteratura, lingua, psicologia, fisica, chimica, architettura, ingegneria, astronomia, religione e pure educazione fisica?”.
Molti uomini, allora, estranei ai ranghi ecclesiastici, quando si incontravano all’osteria, la sera, dopo cena, cominciarono a discutere di filosofia aristotelica la quale, anche attraverso le traduzioni e i commenti dei dotti arabi Avicenna e Averroè, era giunta in Occidente. Così, parla oggi, discuti domani, leggiti il libro per dopodomani, i conversanti aumentavano sempre di più. Gli osti facevano affari d’oro, perché avevano messo la consumazione obbligatoria e, quando si faceva tardi, fittavano pure qualche camera per la notte con la prima colazione compresa. La cuccagna, per i gestori di osterie e taverne, però, durò poco. Ben presto, in tanti decisero di riunirsi in luoghi più adatti alle discussioni, alla lettura e allo studio.
Ed ecco che nacquero le Università e, in due secoli, dall’XI al XIII, ne sorsero in tutta Europa. Ogni città importante aveva la propria. Vi si poteva studiare la filosofia, le lettere, il diritto e le cosiddette arti liberali, fondamento di tutta l’istruzione dei secoli precedenti: la grammatica, la retorica, la dialettica, la musica, l’astronomia, l’aritmetica e la geometria. Tutto era molto ben organizzato: gli studenti, dopo aver letto i testi consigliati dai maestri, sceglievano quale corso seguire e in che materia diventare dotti.
Essi, inoltre, erano liberi di discettare con i docenti, senza dover sostenere esami, né scritti, né orali, ma, semplicemente, confrontando il loro pensiero con quello degli antichi, come, ad esempio, Aristotele e tanti altri, e con i compagni di banco. Era, dunque, un metodo di insegnamento e apprendimento molto particolare. Se oggi fosse ancora così, molti studentelli ne approfitterebbero e non imparerebbero un bel niente…”.