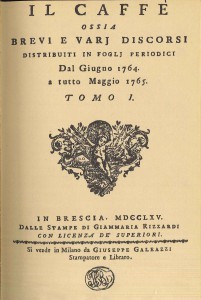Una lunga tradizione di pensiero si è concentrata in un libello dalle origini leggendarie e dalla storia redazionale molto vivace, intitolato Trattato dei tre impostori, dove Mosè, Cristo e Maometto sono stati definiti con l’epiteto del titolo: impostori, appunto. Ne ripercorro, brevemente, le fasi redazionali. L’esistenza di un trattato latino, De tribus impostoribus, sebbene sia stata molte volte affermata e data per certa fin dal XIII secolo, non è mai stata dimostrata, non essendo giunta fino a noi alcuna copia. I probabili autori sono stati identificati, nel tempo, con Averroè, Federico II, Pier delle Vigne, Poggio Bracciolini, Erasmo da Rotterdam, Pietro Aretino, Guillaume Postel, Michele Serveto, Jean Bodin, Bernardino Ochino, Girolamo Cardano, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Giulio Cesare Vanini, Baruch Spinoza e altri. Un secondo trattato latino, sempre intitolato De tribus impostoribus, anonimo, è stato composto nel 1688 e stampato, a Vienna, nel 1753. Un terzo trattato, intitolato La Vie et l’Esprit de Mr Benoît de Spinosa, è stato pubblicato, per la prima volta, anonimo e in francese, a L’Aia, nel 1719. Solo le successive edizioni avrebbero assunto il titolo di Traité des trois imposteurs.
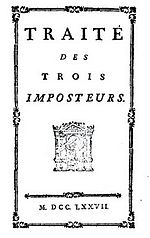 Eccone alcuni passaggi (tratti da Trattato dei tre impostori. La vita e lo spirito del signor Benedetto De Spinosa, Einaudi, 1994): “La stessa nozione di Dio è incerta per coloro che pure ne sostengono l’esistenza, i quali danno «la definizione di Dio ammettendo la loro ignoranza», senza comprendere «chi lo ha creato» o affermando «che è lui stesso il principio di sé», sostenendo così «una cosa che non capiscono. Dicono: non comprendiamo il suo inizio; dunque l’inizio non esiste». Avviene che la sua nozione sia «il limite di un’astrazione intellettuale», e venga definito a volte Natura, a volte Dio, avendone idee disparate. Chi chiama Dio «la connessione delle cose», chi «un essere trascendente, perché non può essere visto né compreso». Si sostiene, poi, che Dio sia amore, benché egli, in quanto creatore, abbia dotato l’uomo di una natura opposta alla sua e lo abbia sottoposto «alla tentazione dell’albero, sapendo che avrebbe commesso una trasgressione fatale a se stesso e ai suoi discendenti». Per riscattare poi la colpa dell’uomo, Dio farà subire a suo figlio i peggiori tormenti: «nemmeno i barbari credono a storie così menzognere». Ci si deve chiedere, allora, perché mai bisognerebbe tributare un culto a Dio, regolato da un’istituzione religiosa, oltre tutto in considerazione del fatto che un essere perfetto non dovrebbe averne bisogno: «il bisogno di essere onorato è segno d’imperfezione e d’impotenza». In realtà, «ognuno comprende che è interesse dei governanti e dei potenti stabilire una religione per mitigare gli istinti violenti del popolo». Si dice che la presenza di una coscienza morale sarebbe la prova che Dio ha dato all’uomo la nozione del bene e del male e conseguente timore della punizione, ma in realtà le cattive azioni alterano l’armonia sociale e chi le commette teme le sanzioni della società umana. È la ragione naturale a illuminare il comportamento morale dell’uomo. Il resto è «un’invenzione dei nostri oziosi sacerdoti, che così accrescono considerevolmente il loro tenore di vita». Nessuna religione è in grado di dimostrare né l’esistenza né la natura di un’essenza divina, anche se sempre vi è chi ha preteso di conoscerla:
Eccone alcuni passaggi (tratti da Trattato dei tre impostori. La vita e lo spirito del signor Benedetto De Spinosa, Einaudi, 1994): “La stessa nozione di Dio è incerta per coloro che pure ne sostengono l’esistenza, i quali danno «la definizione di Dio ammettendo la loro ignoranza», senza comprendere «chi lo ha creato» o affermando «che è lui stesso il principio di sé», sostenendo così «una cosa che non capiscono. Dicono: non comprendiamo il suo inizio; dunque l’inizio non esiste». Avviene che la sua nozione sia «il limite di un’astrazione intellettuale», e venga definito a volte Natura, a volte Dio, avendone idee disparate. Chi chiama Dio «la connessione delle cose», chi «un essere trascendente, perché non può essere visto né compreso». Si sostiene, poi, che Dio sia amore, benché egli, in quanto creatore, abbia dotato l’uomo di una natura opposta alla sua e lo abbia sottoposto «alla tentazione dell’albero, sapendo che avrebbe commesso una trasgressione fatale a se stesso e ai suoi discendenti». Per riscattare poi la colpa dell’uomo, Dio farà subire a suo figlio i peggiori tormenti: «nemmeno i barbari credono a storie così menzognere». Ci si deve chiedere, allora, perché mai bisognerebbe tributare un culto a Dio, regolato da un’istituzione religiosa, oltre tutto in considerazione del fatto che un essere perfetto non dovrebbe averne bisogno: «il bisogno di essere onorato è segno d’imperfezione e d’impotenza». In realtà, «ognuno comprende che è interesse dei governanti e dei potenti stabilire una religione per mitigare gli istinti violenti del popolo». Si dice che la presenza di una coscienza morale sarebbe la prova che Dio ha dato all’uomo la nozione del bene e del male e conseguente timore della punizione, ma in realtà le cattive azioni alterano l’armonia sociale e chi le commette teme le sanzioni della società umana. È la ragione naturale a illuminare il comportamento morale dell’uomo. Il resto è «un’invenzione dei nostri oziosi sacerdoti, che così accrescono considerevolmente il loro tenore di vita». Nessuna religione è in grado di dimostrare né l’esistenza né la natura di un’essenza divina, anche se sempre vi è chi ha preteso di conoscerla: 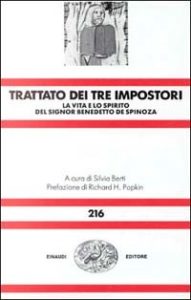 i pagani dell’antichità, il re Numa, Mosé, Maometto, i bramini indiani, i cinesi, ciascuno contraddicendo gli altri. «Si credette che il giudaismo correggesse il paganesimo, il cristianesimo il giudaismo, Maometto entrambi, e si attende il correttore di Maometto e dell’islamismo». È, dunque, naturale sospettare che i fondatori delle religioni siano tutti degli impostori. Del resto, ogni religione accusa tutte le altre di impostura e, in particolare nel cristianesimo, ogni setta cristiana «accusa l’altra di aver corrotto il testo del Nuovo Testamento». Occorrerebbe, poiché non è evidentemente possibile credere a ogni religione, non credere a nessuna, «finché non si sia trovata la vera religione». Pertanto, per stabilire la verità di ogni singola religione, bisognerebbe esaminare con cura le affermazioni dei loro singoli fondatori: «non bisogna prendere affrettatamente per dogma o per testimonianza sicura quel che il primo che passa abbia asserito». Operazione molto difficile, che si può dubitare possa mai giungere a una conclusione effettiva”.
i pagani dell’antichità, il re Numa, Mosé, Maometto, i bramini indiani, i cinesi, ciascuno contraddicendo gli altri. «Si credette che il giudaismo correggesse il paganesimo, il cristianesimo il giudaismo, Maometto entrambi, e si attende il correttore di Maometto e dell’islamismo». È, dunque, naturale sospettare che i fondatori delle religioni siano tutti degli impostori. Del resto, ogni religione accusa tutte le altre di impostura e, in particolare nel cristianesimo, ogni setta cristiana «accusa l’altra di aver corrotto il testo del Nuovo Testamento». Occorrerebbe, poiché non è evidentemente possibile credere a ogni religione, non credere a nessuna, «finché non si sia trovata la vera religione». Pertanto, per stabilire la verità di ogni singola religione, bisognerebbe esaminare con cura le affermazioni dei loro singoli fondatori: «non bisogna prendere affrettatamente per dogma o per testimonianza sicura quel che il primo che passa abbia asserito». Operazione molto difficile, che si può dubitare possa mai giungere a una conclusione effettiva”.
Io credo che Mosè, Cristo e Maometto siano stati sì, impostori, ma filosofici, considerata la sostanziale fallacia dei loro insegnamenti metafisico-teologici, e, allo stesso tempo, li ritengo i più grandi politici della storia, visti gli “iscritti” ai loro “partiti” e quanto questi hanno fatto e continuano a fare in nome loro. Niente di divino o rivelato, quindi. Solo ignoranza, superstizione e credulità da parte di chi, ancora oggi, segue questi tre “segretari di partito” e i loro diktat, da un lato, antivitali, per dirla alla Nietzsche, e, dall’altro, espansionistici. Tutto ciò non fa altro che dimostrare, dunque, la natura esclusivamente politica dell’azione dei tre fondatori di religioni (Ebraismo, Cristianesimo e Islam), come enunciato nel pamphlet, “veri e propri impostori dediti alla gloria personale e all’asservimento dei popoli”.