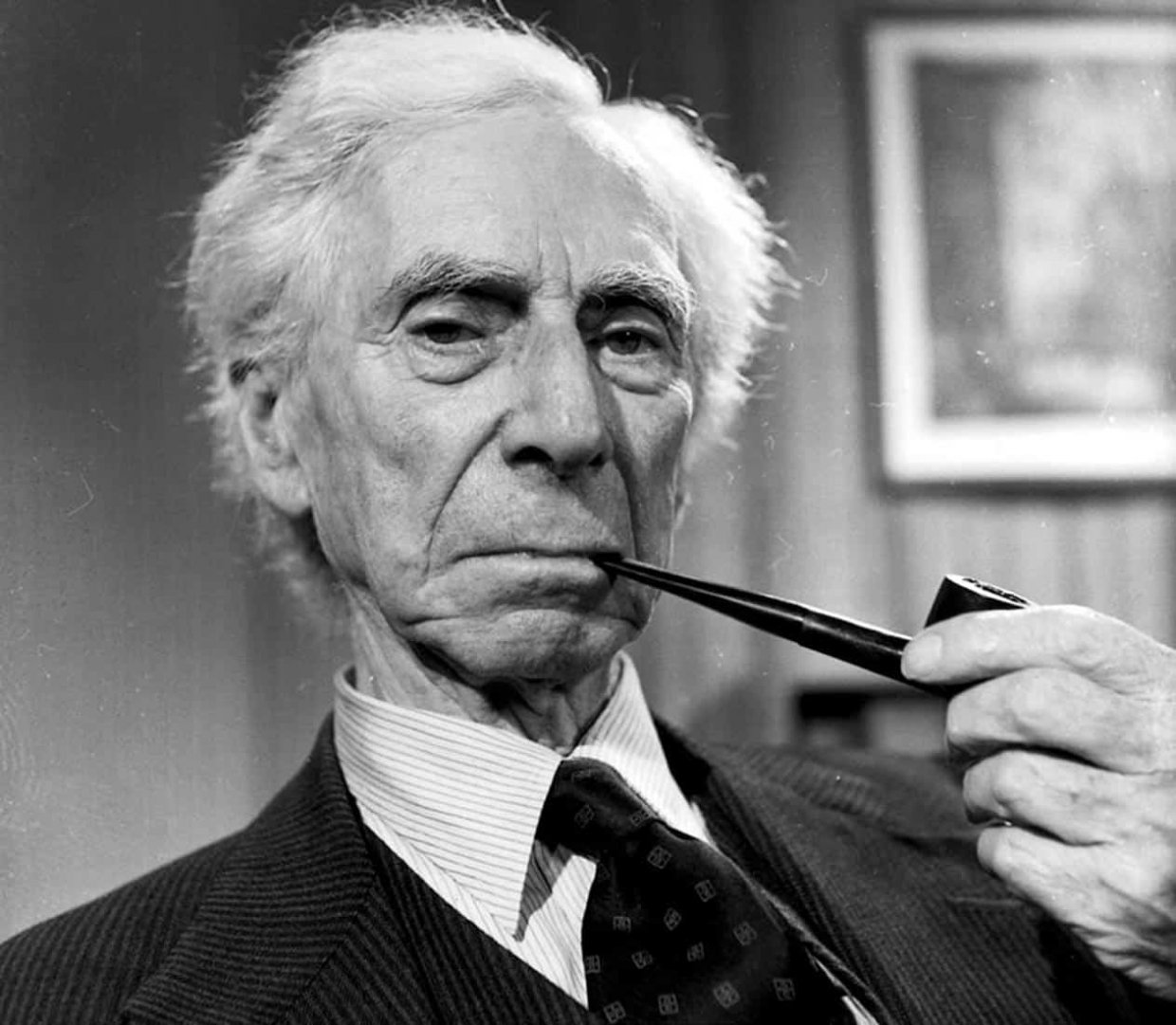Cari ragazzi,
voglio parlarvi di una parola che, a prima vista, sembra distante da voi. Filosofia.
Lo so. A sentirla, il rischio è che subito la vostra mente corra a immagini scolorite: libri pieni di parole difficili, nomi antichi, formule astratte, interrogazioni infinite. La filosofia pare appartenere a un’altra epoca. A un mondo che cammina piano, che ragiona lentamente, mentre voi vivete immersi in una realtà che accelera sempre, che cambia in continuazione, che vi chiede di essere veloci, efficienti, costantemente connessi. Eppure, lasciate che vi dica questo: la filosofia è più vicina a voi di quanto pensiate. E mai come oggi è urgente che le vostre vite si incrocino con essa.
Perché la filosofia non è lusso per intellettuali. Non è sapere elitario, non è esercizio sterile. È, prima di tutto, una forma di vita. Un modo di stare al mondo. È l’arte – antica e sempre nuova – di porsi domande radicali, quelle che toccano il fondo delle cose, quelle che mettono in discussione ciò che diamo per scontato.
E voi, anche se non lo chiamate così, siete pieni di filosofia. Ne siete abitati ogni giorno, senza accorgervene. Vi fate domande vere, spesso nel silenzio delle vostre stanze o nel chiasso dei social. Chi sono? Chi sto diventando? In cosa credo davvero? Come si costruisce un amore che non sia finzione? Qual è il mio posto in questo mondo che sembra scivolare dalle mani? Che senso ha la sofferenza, la morte, la solitudine?
Non sono domande “da adulti”. Non sono domande teoriche. Sono le vostre domande. E sono le stesse che Platone, Spinoza, Kierkegaard, Camus, Simone de Beauvoir si sono posti. La differenza è che a loro è stato detto che quelle domande valevano la pena. Che erano degne. A voi, troppo spesso, si dice il contrario: che pensare è tempo perso, che l’importante è saper vendersi, sapersi adattare, sapersi promuovere. Che bisogna smettere di chiedere e iniziare a fare. Ma chi ha detto che pensare non è fare?
Viviamo in un’epoca affollata di opinioni e povera di pensiero. Dove tutti parlano ma pochi ascoltano. Dove tutto è comunicazione ma quasi nulla è comprensione. In questo rumore assordante, la filosofia è una forma di resistenza. È un atto di libertà. Significa prendersi il diritto di fermarsi, di riflettere, di sospendere il giudizio. Di dire: aspetta, non mi basta quello che mi state dicendo, voglio capire davvero.
È difficile? Sì. Ma non impossibile. È scomodo? Sicuramente. Ma necessario. Perché senza pensiero non c’è libertà. E senza libertà non c’è umanità.

La vostra generazione sta crescendo in mezzo a contraddizioni enormi. Vi si dice che potete essere tutto, ma poi vi si chiede di scegliere in fretta. Vi si dice che siete unici, ma poi vi si misura in base a standard impersonali. Vi si parla di inclusività, ma poi si favorisce l’omologazione. Vi si propone un mondo fluido, ma senza mappe. È normale sentirsi spaesati. È umano sentirsi fragili. Ma proprio lì, in quella fragilità, può nascere qualcosa di potente: la possibilità di pensare, davvero.
La filosofia non vi promette salvezza, né successo. Non vi dà risposte prefabbricate. Vi offre un modo diverso di stare in questo mondo. Vi insegna a guardare con attenzione, a distinguere il vero dal verosimile, a tollerare il dubbio senza esserne schiacciati. Vi insegna che l’intelligenza non è solo calcolo ma anche cura. Che la ragione non è nemica dell’emozione ma suo alleato più profondo. Che la libertà non è fare ciò che si vuole ma diventare ciò che si è.
Vi chiederanno spesso di essere “produttivi”. La filosofia, invece, vi chiederà di essere presenti. Vi chiederanno di avere “risultati”. La filosofia vi chiederà di avere radici. Vi chiederanno di avere certezze. La filosofia vi insegnerà a non averne paura quando queste vacillano.
E vi accorgerete, se vi lascerete toccare, che le parole della filosofia cominciano a parlarvi. Non come formule da memorizzare ma come strumenti per vivere meglio, per vivere con più consapevolezza il tempo che vi è dato. Che un pensiero letto per caso può illuminare un dubbio che vi portavate dentro da anni. Che un filosofo morto da secoli può diventare, un interlocutore, quasi un amico. Perché la vera filosofia non muore. È sempre viva. È sempre attuale. Perché parla dell’umano. E voi siete profondamente, ostinatamente umani.
Vi auguro incontri veri: con docenti che vi parlino, non solo che vi interroghino. Con libri che vi feriscano, non solo che vi formino. Con domande che vi abitino, che non vi lascino in pace. Perché solo chi è abitato da domande profonde può vivere in modo autentico. Vi auguro la pazienza del pensiero, la lentezza del dubbio, il coraggio dell’inquietudine. E, soprattutto, vi auguro di non spegnere mai quella fiamma che vi rende capaci di meravigliarvi. Perché chi si meraviglia non è mai del tutto prigioniero.
La filosofia è per chi non si rassegna. Per chi vuole vedere chiaro anche quando il mondo è opaco. Per chi vuole restare umano, quando tutto intorno spinge alla disumanizzazione. E se avrete il coraggio di continuare a camminare, cessando di fingere di sapere tutto, allora – anche senza accorgervene – sarete filosofi. Non per mestiere: per vocazione.
Non abbiate fretta di diventare. Imparate a essere. E non smettete mai di cercare.
Riccardo