PARTE II
LA COSCIENZA COME CONOSCENZA (Ragion pura) E COME MORALE (Ragion pratica)
 Immanuel Kant, nella sua monumentale opera filosofica, dà al concetto di coscienza una duplice attenzione: una gnoseologica, relativa ai processi della conoscenza, l’altra morale, relativa alla sfera comportamentale. Per quanto riguarda il primo aspetto, considerò la coscienza come appercezione (Leibniz), pur rimanendo nella convinzione dell’esistenza del mondo esterno alla coscienza. Il filosofo di Königsberg (immagine a destra) distinse, poi, le appercezioni in pure trascendentali (chiamate anche “Io penso“), il vertice della conoscenza critica, in quanto fornisce senso alle rappresentazioni della realtà esterna; e in empiriche, l’esperienza interna, variabile e soggettiva. Entrambe le appercezioni e, quindi, la coscienza di esse, concorrono alla formazione dei processi cognitivi. In merito all’aspetto comportamentale, Kant considerò la coscienza come l’elemento che garantisce il valore assoluto della legge morale. La moralità è la somma ultima dei comandamenti della ragione, o imperativi, dai quali l’uomo deriva tutti gli obblighi e i doveri. Kant definisce la morale “Ragione pura pratica“, concependola come un’attività razionale a priori, che risulta sufficiente, da sola, a determinare la volontà. (Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica).
Immanuel Kant, nella sua monumentale opera filosofica, dà al concetto di coscienza una duplice attenzione: una gnoseologica, relativa ai processi della conoscenza, l’altra morale, relativa alla sfera comportamentale. Per quanto riguarda il primo aspetto, considerò la coscienza come appercezione (Leibniz), pur rimanendo nella convinzione dell’esistenza del mondo esterno alla coscienza. Il filosofo di Königsberg (immagine a destra) distinse, poi, le appercezioni in pure trascendentali (chiamate anche “Io penso“), il vertice della conoscenza critica, in quanto fornisce senso alle rappresentazioni della realtà esterna; e in empiriche, l’esperienza interna, variabile e soggettiva. Entrambe le appercezioni e, quindi, la coscienza di esse, concorrono alla formazione dei processi cognitivi. In merito all’aspetto comportamentale, Kant considerò la coscienza come l’elemento che garantisce il valore assoluto della legge morale. La moralità è la somma ultima dei comandamenti della ragione, o imperativi, dai quali l’uomo deriva tutti gli obblighi e i doveri. Kant definisce la morale “Ragione pura pratica“, concependola come un’attività razionale a priori, che risulta sufficiente, da sola, a determinare la volontà. (Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica).
HEGEL: LA COSCIENZA PREMESSA DELL’AUTOCOSCIENZA CHE NON RICERCA L’ASSOLUTO PERCHE’ E’ PARTE DI ESSO
 Al concetto di coscienza, inteso in molteplici significati, il filosofo tedesco George Wilhelm Hegel (immagine a sinistra) dedicò un’intera opera: La fenomenologia dello Spirito. Nella Fenomenologia è tracciato il cammino che la coscienza umana, detta anche individuale, deve compiere per giungere all’Assoluto. La prima tappa è costituita dall’indagine sulla coscienza: l’individuo, attraverso il confronto sensibile con la realtà circostante, ha contezza e, quindi, coscienza della propria esistenza. Tale consapevolezza è generata dalla conoscenza sensibile, dalla percezione e dall’intelletto. Interiorizzata in sé la realtà, la coscienza diviene autocoscienza, seconda tappa. L’autocoscienza che riesce a raggiungere l’indipendenza crede di poter sussistere facendo a meno della realtà. La scissione tra l’autocoscienza e il tutto è chiamata da Hegel “coscienza infelice religiosa“, intesa come spaccatura che l’uomo avverte tra sé e Dio. Giunta al punto più basso di mortificazione e infelicità, l’autocoscienza si rende conto che è inutile ricercare l’Assoluto in quanto essa stessa è parte dell’Assoluto. Allora diviene Ragione, terza ed ultima tappa del percorso.
Al concetto di coscienza, inteso in molteplici significati, il filosofo tedesco George Wilhelm Hegel (immagine a sinistra) dedicò un’intera opera: La fenomenologia dello Spirito. Nella Fenomenologia è tracciato il cammino che la coscienza umana, detta anche individuale, deve compiere per giungere all’Assoluto. La prima tappa è costituita dall’indagine sulla coscienza: l’individuo, attraverso il confronto sensibile con la realtà circostante, ha contezza e, quindi, coscienza della propria esistenza. Tale consapevolezza è generata dalla conoscenza sensibile, dalla percezione e dall’intelletto. Interiorizzata in sé la realtà, la coscienza diviene autocoscienza, seconda tappa. L’autocoscienza che riesce a raggiungere l’indipendenza crede di poter sussistere facendo a meno della realtà. La scissione tra l’autocoscienza e il tutto è chiamata da Hegel “coscienza infelice religiosa“, intesa come spaccatura che l’uomo avverte tra sé e Dio. Giunta al punto più basso di mortificazione e infelicità, l’autocoscienza si rende conto che è inutile ricercare l’Assoluto in quanto essa stessa è parte dell’Assoluto. Allora diviene Ragione, terza ed ultima tappa del percorso.
LA COSCIENZA COME RIFLESSO DELLA REALTA’ MATERIALE
 Per Karl Marx (immagine a destra) la coscienza, come la produzione di idee e di rappresentazioni mentali, è direttamente collegata alle attività materiali degli uomini. Anche la produzione spirituale, che si manifesta nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale e della religione, è una conseguenza dei comportamenti materiali. Gli uomini, intesi quali reali, operanti e condizionati dallo sviluppo delle loro forze produttive e dalle relazioni che vi corrispondono, sono i produttori delle loro rappresentazioni. La coscienza, quindi, è l’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il processo reale della loro vita. Gli uomini, sviluppando la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali, trasformano, insieme con la loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è, dunque, la coscienza a determinare la vita, ma la vita a determinare la coscienza (Ideologia Tedesca).
Per Karl Marx (immagine a destra) la coscienza, come la produzione di idee e di rappresentazioni mentali, è direttamente collegata alle attività materiali degli uomini. Anche la produzione spirituale, che si manifesta nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale e della religione, è una conseguenza dei comportamenti materiali. Gli uomini, intesi quali reali, operanti e condizionati dallo sviluppo delle loro forze produttive e dalle relazioni che vi corrispondono, sono i produttori delle loro rappresentazioni. La coscienza, quindi, è l’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il processo reale della loro vita. Gli uomini, sviluppando la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali, trasformano, insieme con la loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è, dunque, la coscienza a determinare la vita, ma la vita a determinare la coscienza (Ideologia Tedesca).
LA COSCIENZA NEL PENSIERO FILOSOFICO CONTEMPORANEO
Con Edmund Husserl il concetto di coscienza, arricchito dalle dottrine dei filosofi dei secoli precedenti, conquista il passaggio verso il pensiero contemporaneo. Se per Hegel il termine 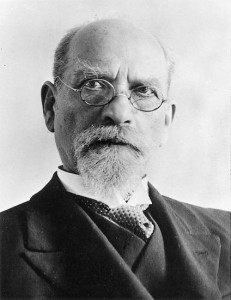 fenomenologia aveva significato tracciare il cammino della coscienza, per Husserl (immagine a sinistra), invece, ineriva proprio lo studio della coscienza. Il filosofo prese le distanze dallo Spiritualismo del XIX secolo, per cui la coscienza era una sostanza, un ente, sostenendo che questa non fosse, appunto, un essenza, ma un’attività. In più, essa è anche intenzionalità, ovvero coscienza di qualcosa e si presenta in diversi modi: percepire, pensare, ricordare, immaginare. La coscienza, però – e qui c’è la rottura con tutta la tradizione precedente -, non si identifica col suo oggetto. Essa è totalmente soggettiva. Solo la coscienza può rivelare l’essere: essere è solo ciò che è per la coscienza. Da ciò, l’originale intreccio husserliano tra coscienza e filosofia: teoretica (filosofia di riflessione, di contemplazione, poiché riguarda sempre il soggetto conoscente); edetica (che si occupa delle essenze, non avendo un rapporto diretto con la realtà come essa è ma come appare alla coscienza); non oggettiva (l’approdo cui giungono le sue posizioni è estremamente soggettivo) (Ricerche logiche, Meditazioni cartesiane). Come Husserl, anche Martin Heidegger muove la sua analisi della coscienza
fenomenologia aveva significato tracciare il cammino della coscienza, per Husserl (immagine a sinistra), invece, ineriva proprio lo studio della coscienza. Il filosofo prese le distanze dallo Spiritualismo del XIX secolo, per cui la coscienza era una sostanza, un ente, sostenendo che questa non fosse, appunto, un essenza, ma un’attività. In più, essa è anche intenzionalità, ovvero coscienza di qualcosa e si presenta in diversi modi: percepire, pensare, ricordare, immaginare. La coscienza, però – e qui c’è la rottura con tutta la tradizione precedente -, non si identifica col suo oggetto. Essa è totalmente soggettiva. Solo la coscienza può rivelare l’essere: essere è solo ciò che è per la coscienza. Da ciò, l’originale intreccio husserliano tra coscienza e filosofia: teoretica (filosofia di riflessione, di contemplazione, poiché riguarda sempre il soggetto conoscente); edetica (che si occupa delle essenze, non avendo un rapporto diretto con la realtà come essa è ma come appare alla coscienza); non oggettiva (l’approdo cui giungono le sue posizioni è estremamente soggettivo) (Ricerche logiche, Meditazioni cartesiane). Come Husserl, anche Martin Heidegger muove la sua analisi della coscienza  dalla soggettività di questa, mettendo, però, in luce che gli sforzi di Husserl non siano bastati, avendo questi non tenuto conto anche della finitezza e della esistenza storica. Il filosofo tedesco (immagine a destra) insiste sull’esigenza di connettere la coscienza alla concretezza dell’esistenza. L’essere, progettando il mondo, lo fa venire all’esistenza, in quanto coscienza trascendentale, trovandosi, quindi, ad essere a sua volta progettato. L’essere, avendo coscienza della propria esistenza si apre al mondo, uscendo dalla soggettività per entrare nell’universo della coesistenza fra le cose. Tale azione aliena l’essere da sé stesso. La conseguenza è l’appello alla coscienza, ma questa apre la prospettiva al nulla, al nichilismo (Essere e tempo). Jean Paul Sartre, ponendosi tra la fenomenologia di Husserl e l’esistenzialismo di Heidegger, trasforma la filosofia della coscienza in esistenzialismo ateo, negando l’esistenza dell’io nella coscienza e trasportandolo al di fuori di essa, come ente del mondo. L’esistenza è la nullificazione dell’essere, poiché l’essere è affetto da una frattura insanabile tra l’essere in sé, come totalità fuori dalla coscienza, e l’essere per sé, che è l’essere della coscienza stessa. L’essere non riesce mai ad afferrare sé stesso. Ha in sé la tara del nulla. Da qui, la nullificazione del mondo, poiché le cose sono quelle che sono in sé, ma non ne hanno coscienza. Esse non hanno senso, come non ha senso la coscienza umana; sono una realtà di fronte alla quale l’unico atteggiamento possibile della coscienza umana non può che essere la nausea (Saggi, La nausea). Con Sigmund Freud e la sua scuola il concetto di coscienza entra nella psicoanalisi moderna. Per esigenze di brevità, data la vastità del pensiero freudiano, mi limito a fornire accenni esplicativi sui più importanti contributi che lo psicoanalista austriaco ha fornito alla scienza contemporanea, con l’indagine della mente umana e dei suoi processi: i concetti di coscienza, preconscio e inconscio. La coscienza è
dalla soggettività di questa, mettendo, però, in luce che gli sforzi di Husserl non siano bastati, avendo questi non tenuto conto anche della finitezza e della esistenza storica. Il filosofo tedesco (immagine a destra) insiste sull’esigenza di connettere la coscienza alla concretezza dell’esistenza. L’essere, progettando il mondo, lo fa venire all’esistenza, in quanto coscienza trascendentale, trovandosi, quindi, ad essere a sua volta progettato. L’essere, avendo coscienza della propria esistenza si apre al mondo, uscendo dalla soggettività per entrare nell’universo della coesistenza fra le cose. Tale azione aliena l’essere da sé stesso. La conseguenza è l’appello alla coscienza, ma questa apre la prospettiva al nulla, al nichilismo (Essere e tempo). Jean Paul Sartre, ponendosi tra la fenomenologia di Husserl e l’esistenzialismo di Heidegger, trasforma la filosofia della coscienza in esistenzialismo ateo, negando l’esistenza dell’io nella coscienza e trasportandolo al di fuori di essa, come ente del mondo. L’esistenza è la nullificazione dell’essere, poiché l’essere è affetto da una frattura insanabile tra l’essere in sé, come totalità fuori dalla coscienza, e l’essere per sé, che è l’essere della coscienza stessa. L’essere non riesce mai ad afferrare sé stesso. Ha in sé la tara del nulla. Da qui, la nullificazione del mondo, poiché le cose sono quelle che sono in sé, ma non ne hanno coscienza. Esse non hanno senso, come non ha senso la coscienza umana; sono una realtà di fronte alla quale l’unico atteggiamento possibile della coscienza umana non può che essere la nausea (Saggi, La nausea). Con Sigmund Freud e la sua scuola il concetto di coscienza entra nella psicoanalisi moderna. Per esigenze di brevità, data la vastità del pensiero freudiano, mi limito a fornire accenni esplicativi sui più importanti contributi che lo psicoanalista austriaco ha fornito alla scienza contemporanea, con l’indagine della mente umana e dei suoi processi: i concetti di coscienza, preconscio e inconscio. La coscienza è 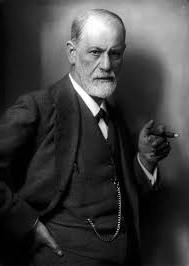 facilmente accessibile perché in stretta e immediata connessione con la realtà che ci circonda: essa è sempre vigile, razionale, presente e non vive, perciò, di ricordi passati. Freud (immagine a sinistra) considera la coscienza come un dato dell’esperienza individuale. La assimila alla percezione, considera come essenza di quest’ultima la capacità di ricevere qualità sensibili e affida questa funzione di percezione-coscienza ad un sistema autonomo e funzionante in base a principi quantitativi. Tra la coscienza e l’inconscio, è collocato il preconscio. Esso incamera tutte le esperienze passate, che possono essere fatte emergere con facilità: attraverso uno sforzo, grande o piccolo, dipende dal ricordo, si può riscoprire qualcosa che è accaduto. Al preconscio, dunque, vi si può accedere grazie alla ragione, senza grosse difficoltà. L’inconscio. In esso risiedono desideri vergognosi, impulsi repressi, esperienze traumatiche rimosse. Tutto ciò che si vuole cancellare definitivamente e domare con la ragione si inabissa in questo spazio di ricordo eterno. Tutto ciò che accade o è accaduto in un passato, anche remotissimo, viene divorato dall’inconscio e mai viene dimenticato (L’interpretazione dei sogni).
facilmente accessibile perché in stretta e immediata connessione con la realtà che ci circonda: essa è sempre vigile, razionale, presente e non vive, perciò, di ricordi passati. Freud (immagine a sinistra) considera la coscienza come un dato dell’esperienza individuale. La assimila alla percezione, considera come essenza di quest’ultima la capacità di ricevere qualità sensibili e affida questa funzione di percezione-coscienza ad un sistema autonomo e funzionante in base a principi quantitativi. Tra la coscienza e l’inconscio, è collocato il preconscio. Esso incamera tutte le esperienze passate, che possono essere fatte emergere con facilità: attraverso uno sforzo, grande o piccolo, dipende dal ricordo, si può riscoprire qualcosa che è accaduto. Al preconscio, dunque, vi si può accedere grazie alla ragione, senza grosse difficoltà. L’inconscio. In esso risiedono desideri vergognosi, impulsi repressi, esperienze traumatiche rimosse. Tutto ciò che si vuole cancellare definitivamente e domare con la ragione si inabissa in questo spazio di ricordo eterno. Tutto ciò che accade o è accaduto in un passato, anche remotissimo, viene divorato dall’inconscio e mai viene dimenticato (L’interpretazione dei sogni).





